
Come sempre, la dialettica porta dibattito e nuove riflessioni. Avevamo già annunciato l’uscita del volume J.R.R.Tolkien l’esperantista – prima dell’arrivo di Bilbo Baggins curato da Oronzo Cilli (Cafagna Editore, 2015), pubblicando la prefazione che ne aveva scritto lo studioso inglese John Garth, che potete leggere qui. Ora eccovi una recensione ad opera di Wu Ming 4, socio fondatore Aist e noto scrittore del collettivo omonimo e soprattutto, in questa sede, autore di diverse pubblicazioni dedicate a J.R.R. Tolkien (oltre che di un romanzo Stella del mattino), l’ultimo dei quali Difendere la Terra di Mezzo in cui è riuscito brillantemente, come scrive lui stesso, a «divulgare alcune tesi e punti di vista sull’opera di Tolkien che sono soprattutto patrimonio della comunità degli studiosi e di renderli accessibili a una platea più vasta», oltre a presentare acute analisi su temi e personaggi delle opere di Tolkien. È per questo motivo che siamo lieti di proporre ai lettori una recensione di chi i libri li legge e analizza in profondità. Buona lettura!
Tag: Patrick H. Wynne
Tolkien l’esperantista: la prefazione di Garth
 È disponibile da oggi sul sito dell’editore il volume Tolkien l’esperantista, – Prima dell’arrivo di Bilbo Baggins, (Cafagna editore, 160 pp., 15 euro) collectanea di saggi che ricostruisce, grazie al lavoro di Oronzo Cilli, Arden R. Smith, e Patrick H. Wynne, il rapporto J.R.R. Tolkien e l’Esperanto, la lingua pianificata da Ludwik L. Zamenhof, la più conosciuta tra le lingue ausiliarie internazionali e oggi parlata da più di due milioni di persone.
È disponibile da oggi sul sito dell’editore il volume Tolkien l’esperantista, – Prima dell’arrivo di Bilbo Baggins, (Cafagna editore, 160 pp., 15 euro) collectanea di saggi che ricostruisce, grazie al lavoro di Oronzo Cilli, Arden R. Smith, e Patrick H. Wynne, il rapporto J.R.R. Tolkien e l’Esperanto, la lingua pianificata da Ludwik L. Zamenhof, la più conosciuta tra le lingue ausiliarie internazionali e oggi parlata da più di due milioni di persone.
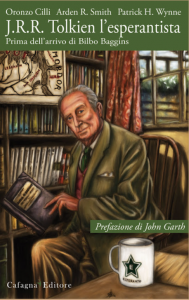 Il libro illustra le esperienze dello scrittore inglese con i linguaggi inventati e analizza approfonditamente il primo approccio con l’Esperanto a partire da un suo taccuino del 1909 da lui titolato Book of the Foxrook, per passare a riflessioni più accademiche nel suo saggio A Secret Vice, pubblicato postumo, fino a giungere al suo impegno attivo negli anni Trenta a favore della lingua inventata da Zamehof e la sua partecipazione ai convegni esperantisti organizzati a Oxford. In occasione di questa uscita riportiamo la prefazione del libro, affidata a John Garth. Si tratta di uno dei più importanti studiosi di Tolkien, autore di Tolkien e la Grande Guerra. La soglia della Terra di Mezzo (Marietti 1820, 2007) e Tolkien at Exeter College (Exeter College, 2014), oltre a essere socio onorario della nostra Associazione.
Il libro illustra le esperienze dello scrittore inglese con i linguaggi inventati e analizza approfonditamente il primo approccio con l’Esperanto a partire da un suo taccuino del 1909 da lui titolato Book of the Foxrook, per passare a riflessioni più accademiche nel suo saggio A Secret Vice, pubblicato postumo, fino a giungere al suo impegno attivo negli anni Trenta a favore della lingua inventata da Zamehof e la sua partecipazione ai convegni esperantisti organizzati a Oxford. In occasione di questa uscita riportiamo la prefazione del libro, affidata a John Garth. Si tratta di uno dei più importanti studiosi di Tolkien, autore di Tolkien e la Grande Guerra. La soglia della Terra di Mezzo (Marietti 1820, 2007) e Tolkien at Exeter College (Exeter College, 2014), oltre a essere socio onorario della nostra Associazione.
Convegni e università per le lingue elfiche
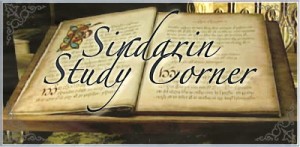 Chi è veramente interessato alle lingue inventate da J.R.R. Tolkien si sarà già accorto ci come negli ultimi tempi questo campo di studi stia acquisendo sempre maggiore attenzione da parte degli studiosi. La novità è il respiro internazionale che ormai hanno assunto questi studi, tanto da entrare stabilmente all’università. Un convegno internazionale si sta svolgendo in Finlandia, mentre un seminario approfondito della durata di quasi due settimane si svolgerà alla Libera Università di Bruxelles, in Belgio. Tutto questo mentre due delle riviste più attive dedicate alle lingue tolkieniane pubblicheranno un nuovo numero. Ma iniziamo proprio da queste ultime.
Chi è veramente interessato alle lingue inventate da J.R.R. Tolkien si sarà già accorto ci come negli ultimi tempi questo campo di studi stia acquisendo sempre maggiore attenzione da parte degli studiosi. La novità è il respiro internazionale che ormai hanno assunto questi studi, tanto da entrare stabilmente all’università. Un convegno internazionale si sta svolgendo in Finlandia, mentre un seminario approfondito della durata di quasi due settimane si svolgerà alla Libera Università di Bruxelles, in Belgio. Tutto questo mentre due delle riviste più attive dedicate alle lingue tolkieniane pubblicheranno un nuovo numero. Ma iniziamo proprio da queste ultime.
Le lingue di J.R.R. Tolkien. Esce Vinyar Tengwar 50
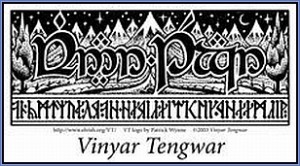 Per tutti gli appassionati di J.R.R. Tolkien che sono interessati ai suoi linguaggi inventati, una notizia molto gradita giunge da Carl F. Hostetter. Il cinquantesimo numero della rivista linguistica specializzata curata dalla Elvish Linguistic Fellowship (la Compagnia Linguistica Elfica, abbreviato E.L.F.), Vinyar Tengwar, è finalmente all’orizzonte! Per gli esperti di lingue tolkieniane la Elf è una vera e proprio istituzione, continua fonte primaria di perle linguistiche.
Per tutti gli appassionati di J.R.R. Tolkien che sono interessati ai suoi linguaggi inventati, una notizia molto gradita giunge da Carl F. Hostetter. Il cinquantesimo numero della rivista linguistica specializzata curata dalla Elvish Linguistic Fellowship (la Compagnia Linguistica Elfica, abbreviato E.L.F.), Vinyar Tengwar, è finalmente all’orizzonte! Per gli esperti di lingue tolkieniane la Elf è una vera e proprio istituzione, continua fonte primaria di perle linguistiche.
