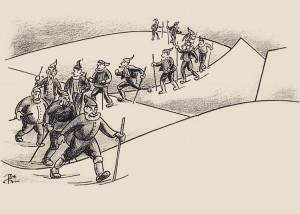 Buon Natale! O meglio, dovremmo dire «Buon Yule», come scrive J.R.R. Tolkien in una lettera (n. 347). L’equivalenza tra Natale e Yule è una delle lezioni trasmesse dalle sue opere, ma in realtà, come spesso accade, si tratta solo di un errore della traduzione italiana. Nello Hobbit pubblicato da Adelphi e tradotto da Elena Jeronimidis Conte, il termine “Yule-tide” appare infatti tradotto in italiano come “periodo natalizio”. Intervistato dall’Oxford Times (il 22 dicembre 1972), l’autore separava nettamente i due termini spiegando che «non c’è niente che non mi piace nel Natale, in particolare; io l’ho soltanto diviso in due. C’è “Yule”, che significa la parte dei regali, dell’albero di Natale e di queste cose; e poi c’è il “Natale”, che è la festa religiosa e della pace». Per capire meglio, passiamo in rassegna l’uso del termine nelle opere di Tolkien.
Buon Natale! O meglio, dovremmo dire «Buon Yule», come scrive J.R.R. Tolkien in una lettera (n. 347). L’equivalenza tra Natale e Yule è una delle lezioni trasmesse dalle sue opere, ma in realtà, come spesso accade, si tratta solo di un errore della traduzione italiana. Nello Hobbit pubblicato da Adelphi e tradotto da Elena Jeronimidis Conte, il termine “Yule-tide” appare infatti tradotto in italiano come “periodo natalizio”. Intervistato dall’Oxford Times (il 22 dicembre 1972), l’autore separava nettamente i due termini spiegando che «non c’è niente che non mi piace nel Natale, in particolare; io l’ho soltanto diviso in due. C’è “Yule”, che significa la parte dei regali, dell’albero di Natale e di queste cose; e poi c’è il “Natale”, che è la festa religiosa e della pace». Per capire meglio, passiamo in rassegna l’uso del termine nelle opere di Tolkien.
Tag: Elena Jeronimidis Conte
Editori e traduttori: gli errori in Tolkien
Aprire un libro è entrare in un mondo. Ma a pochi lettori viene in mente che dietro l’oggetto c’è il lavoro di molte persone oltre l’autore. Su tutti, l’editore, il traduttore se il libro è di uno scrittore straniero e l’illustratore. Ognuna di queste tre figure passa molte ore sul testo, ma pochi sanno che il libro che giunge loro è frutto di una serie di scelte. E fra i tre ruoli citati, forse l’ultimo è quello che può fare meno danni, mentre gli altri due possono produrre gli errori più duraturi. Passiamo, quindi, in rassegna il lavoro di editori e traduttori in generale, prima di concentrarsi su J.R.R. Tolkien.
…